5
feb
2009
Dal vecchio al nuovo testamento. (Di Salvatore Cambosu)
BREVE NOTA BIOGRAFICA
Salvatore Cambosu nasce a Orotelli il 5 gennaio 1895 e cresce sotto la guida del padre Gavino (zio da parte materna della Deledda) e della madre Grazia Nieddu accanto ai suoi numerosi fratelli e sorelle – Gavino, Battistina, Nicolina, Sebastiano, Andrea, Antonietta e Grazia.
Si avvia alla carriera di insegnante nelle Elementari di Orotelli e di altri villaggi della provincia di Nuoro e, dopo una parentesi politica (fu amministratore dal 1923 al 1926 del comune di Orotelli dove realizzò diverse opere pubbliche fra cui la pavimentazione a selciato di tutte le strade), si trasferisce a Cagliari dove insegna in vari istituti.
Intraprende nel contempo l’attività pubblicistica con articoli, racconti e novelle che appaiono su Il Messaggero, Il Corriere d’Italia, Il Popolo Romano e sulla rivista Noi e il Mondo e sin da quei primi articoli si manifesta l’interesse dello scrittore per i problemi dell’Isola (specie quelli sull’identità dei Sardi) che costituiranno la materia delle sue importanti collaborazioni future.
DAL VECCHIO AL NUOVO TESTAMENTO
Tratto da Miele Amaro di Salvatore Cambosu
Era solito dire Stefano Virde, il quale si atteneva per lo più alle favole antiche, che, di un intero continente 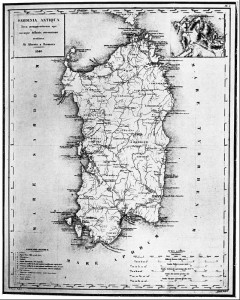 caduto in disgrazia, Dio salvò unicamente quest’isola perché era abitata da una gente laboriosa e di semplici costumi.
caduto in disgrazia, Dio salvò unicamente quest’isola perché era abitata da una gente laboriosa e di semplici costumi.
Stefano Virde amava troppo la sua terra, l’amava ciecamente: ne nascondeva i difetti e ne ingrandiva i pregi: tanto che non permetteva a nessuno, neppure ai suoi figli (che erano andati raminghi in cerca di lavoro, nei continenti estraeuropei), e neppure ai suoi nipoti (che avevano passato il mare per fare le guerre): non permetteva nemmeno a loro di far dell’ironia sul conto del Sardo che ha, fra i suoi vezzi principali, anche quello d’appartarsi e di mettersi a cantare nelle solitudini, come uno che pianga di nascosto.
Molti secoli prima che Stefano Virde nascesse, un terribile vescovo, Lucifero di Cagliari, era arrivato ad affermare che il pontefice di Roma era incorso in errore, reintegrando nella loro dignità i pastori d’anime che erano ritornati all’ovile, già fautori dell’eresia d’Ario, al fianco dell’imperatore Costanzo, contro Atanasio:1 errore tanto grave, a suo parere, che anche come reduce dall’esilio (che aveva scontato nella Tebaide con dignità ed estremo coraggio e aperto vilipendio di Costanzo che glie lo aveva inflitto) si sentiva autorizzato a mettersi in rotta con la Curia romana, e a proclamare la Sardegna immune da lue eretica, e perciò la sola sede che fosse rimasta degna di Cristo. Il che faceva dire con sarcasmo a San Gerolamo: il Figlio di Dio non essere disceso ob tantum Sardorum mastrucam.
Così, l’inflessibile e intransigente presule e Stefano Virde, a distanza di secoli l’uno dall’altro, mostravano di essere della stessa pasta e commettevano il medesimo errore: di impermalirsi, d’inselvatichirsi, di separarsi dal mondo, d’isolarsi, di diffidare della gente e delle cose di fuori.
Ancora oggi, dopo la loro morte (l’uno è relegato nel limbo dei santi di tollerato culto provinciale, l’altro dorme in un cimitero di campagna) ancora oggi si sente dire da qualcuno, ma sempre più di rado: «Pinta la legna e mandala in Sardegna»: adagio, che, sostanzialmente, esprime forte diffidenza verso il forestiero.
Vero è che anche nel passato il Sardo seppe distinguere il grano dal loglio. Sempreché infatti il forestiero veniva come ospite o visitatore o studioso, il Sardo si faceva in quattro per onorarlo. Sa domo est minore – gli diceva – su coro est mannu. Che se poi qualche ospite, ritornato a casa sua, illuso d’aver tutto compreso s’è voluto far bello con scoperte inverosimili e con qualche malignità intinta nell’inchiostro, soltanto lui sfigurò e continua a sfigurare. Ma tornano sempre grati alla memoria i nomi di ospiti che hanno fatto onore a se stessi con opere che ogni Sardo dovrebbe avere nella sua biblioteca: dove anche le verità più crude non furono taciute, ma il tono era, e rimane, dell’amico, del poeta, dell’indagatore, dello studioso che prepara il terreno al pioniere, al clinico, all’ingegnere.
Gli stranieri che arrivarono in armi nell’isola dal mare e la sopraffecero e le camminarono sul cuore, la gente o non li nomina, o se li nomina, esce in frasi come questa: Su fogu si los mandighet (il fuoco li divori).
Di dominazione in dominazione mentre la malaria, la consanguineità e la denutrizione li decimavano, i Sardi arrivarono alla conclusione desolata: Pal noi non v’ha meddori / né impolta qual ha vintu / sia iddu Filippu chintu / o Carlu imperadori .2 E, peggio, si ridussero a ripiegare su se stessi, a litigare tra vicini, a essere malunidos per non smentire Carlo V, a chiudere la porta alla speranza, a canticchiare mestamente, sempre più numerosi, nelle solitudini più squallide; a conversare giorno e notte con la Morte. – Dobbiamo scontare un peccato? Scontiamolo pure – diceva il nonno di Stefano Virde. – Quale, mi domandi? Tutto quello che ti posso rispondere, figlio mio, è questo: che è colpa della stirpe, un peccato oscuro e nero, un astro di fuoco nero –. Era il mito della cattiva stella: il complesso dei “malfatati”; mito che s’era venuto radicando nei secoli, oltre che per il tragico delle invasioni e delle incursioni barbaresche, anche per gli eroismi sfortunati a cominciare dai più remoti, in parte avvolti in un alone di leggenda. Un lungo e sanguinoso elenco: da Amsicora al nome del più umile fantaccino, inciso nella lapide dei caduti, nel più ignorato dei paesetti.
Amsicora, capo dell’esercito sardo e anima della sollevazione contro Roma, il quale riesce a fuggire dopo la sconfitta inflittagli da Tito Manlio e, mentre riorganizza la lotta, si uccide al messaggio che suo figlio, il giovinetto Iosto, è morto sul campo con le vene aperte e con la faccia contro il nemico.3 Stefano Virde con innocente boria dava per certo, come glielo avevano tramandato gli avi, che quel vecchio soldato, prima di morire, aveva detto che la sua pelle era incartapecorita ma che alla riscossa poteva servire per un tamburo da battaglia.
La legislatrice Eleonora d’Arborea: che innalzò la bandiera dell’indipendenza contro Aragona e che, forse, morì come una santa assistendo gli appestati. Di essa Stefano Virde raccontava, sulla fede degli avi, che, come donna, era un uomo dei più animosi.
La stessa che il fiero prete Muroni, allorché sotto la bandiera d’Angioy aveva sposato, dopo la parrocchia di Semestene, la causa degli oppressi contro i feudatari (i cavalli di stalla), proclamava la Giovanna d’Arco dei Sardi.
E il giudice di Bono non s’era messo alla testa di quell’esercito di schiavi? E non gli apriva la marcia un vento che faceva martellare da sole tutte le campane dei borghi? E a che era valso? Perché s’accaniva così contro di noi la sorte?
E poi tutti quelli che morirono nelle sabbie, nel fango delle trincee, nei mari e nelle nevi.
Per tutto questo e anche a causa delle pesti – una peste, una chiesa di campagna – e anche a causa dei rovesci stagionali e delle bibliche locuste, un Sardo lo pensava, due Sardi che s’incontrassero se lo confidavano, ma sottovoce per non svegliare il destino: Dio non grida ma giudica (Deus non jubilat ma judicat): e, senza volerlo, calcavano l’accento su quest’ultima parola. Perché, da non si sa quanto tempo, e quasi fino a ieri, il pastore alla grande disponeva nella sua capanna d’una Bibbia che con tutti quei patriarchi gli teneva compagnia nelle solitudini: e lui, l’anacoreta, la compitava sempre arrestandosi però alle soglie del Vangelo, come un escluso. Tutt’al più, se si attentava a entrare in quel paese promettente, egli si fermava a fare gruppo coi pastori invitati dagli angeli in quella antica notte di dicembre; ma, dopo quell’omaggio, sentendosi di stirpe reietta, non s’inoltrava, anzi ritornava con sconforto, come a luoghi di vita anteriore, all’Egitto flagellato o alla casa decaduta di Giobbe.
Lo stesso maggior poeta della Sardegna4 si lasciò verso quel tempo scoraggiare, almeno per un momento, dalle sfortune e dai lutti della sua gente, a tal punto che, rivolgendosi alle madri, avvalorava il mito della cattiva stella con questi disperati e astratti accenti oratori: «O Madri o Madri! i cieli vi mentirono, e mentito / Vi ha nei secoli Gesù: / E il suo regno non venne, e quel sogno è svanito / E non tornerà mai più». Così, non si può dire che i Sardi andassero alla festa – ma già sperano di potervi andare – per divertirsi. Andavano alle feste, e in gran parte le frequentano ancora, piuttosto per stordirsi, per dimenticare. Per nascondere l’ansia e la cupezza nel tumulto e nell’allegria rumorosa; o nelle danze ora troppo composte, quasi ieratiche, ora addirittura frenetiche; e gli stessi carnevali o sono ebbri di selvatici gridi, o consistono in quasi funebri silenzi che pesano come pietra. Allegria chiusa e malata: recita convenzionale, dove tutti prendono la maschera: e in quel carnevale non resta che un solo spettatore che nessuno vede e tutti sentono: il Dio del Vecchio Testamento, l’irato Dio dei fulmini.
Le ore morte sono così in soprannumero sulle ore vive: molto si esiste e poco si vive, se vivere significa, almeno, dormire un sonno sano e profondo e ridere spontaneamente di cuore; e se esistere significa sopra tutto la monotonia, le launeddas ,5 il malinteso, il ripicco, il litigio, la bruttezza del tugurio, Lodé, Lodine, Lollove,6 la malattia storica che ha lasciato, e lascia ancora, scarso margine all’iniziativa dell’individuo e alla esperienza personale, la paralisi della volontà, la precarietà, le ore avvelenate dalle ombre e dai sospetti.
Anche il paesaggio, che è vario quanto mai di contrada in contrada, il Sardo stava sul punto di perderlo definitivamente: egli si inselvatichiva fino a odiarlo: e lo feriva con la scure e lo inceneriva con l’incendio doloso.
Ma già egli non crede più nelle Janas 7 che custodiscono i tesori con tanta gelosia da vendicarsi sul minatore, seppellendolo con le frane e abbreviandogli la vita con le malattie. Egli crede, invece, nella tecnica e nella medicina.
Può essere rimasta Vincenza Urru a parlar del diavolo che presiede all’oro e lo fa carbone. I figli sanno bene che tra oro e carbone corre stretta parentela. Può essere rimasto un qualsiasi Bonaventura Vedimorti come depositario ultimo e screditato del rimedio che, per allontanare la morte dai giovani, basti appendere all’uscio della stanza dell’infermo una falce messoria.
Il Sardo ormai crede molto di più nei sieri, dei quali ha esperimentato gli effetti anche sulle sue bestie. Ha visto che la zanzara è stata distrutta, ed è arrivato al punto di ridersi della leggenda che non vale muovere un dito.
Ha scritto sul ponte del Cedrino:8 «Vincerà l’uomo o la zanzara?». E una mano ha risposto: «L’uomo ha vinto». E ormai sa che l’uomo è destinato a grandi cose. Arriva a dire tutto questo con la frase: «Il forestiero, quante ne inventa» che è il rovescio dell’adagio: «Pinta la legna…».
Se le fiumane e le acque precipitose o sotterranee causano lutti e rovine, egli non ricorre più ai maghi che le esorcizzino, come avveniva al tempo di Stefano Virde: chiede, invece, l’intervento dei tecnici.
Se le cavallette s’abbattono come nembi e con le loro scimitarre sono più nefaste delle stesse orde saracene d’una volta, non ricorre più al fattucchiere che le scacci come figlie del demonio: suona, invece, le campane a stormo e scende in battaglia.
Basterà perciò assecondarlo perché continui su questa strada, lungo la quale, come già presente e spera, incontrerà il Dio del Nuovo Testamento, quello che (come è solito esprimersi uno dei più giovani nipoti di Stefano Virde e figlio del grande capitano Giuseppe Tropea) chiama ogni tanto Pietro e gli dice: – Che te ne pare dell’uomo che vedo laggiù, uno che sta facendo di tutto per aiutarsi? Io direi, Pietro, che meriti subito una mano d’aiuto.
————————————————————————-
1. Lucifero, vescovo di Cagliari. Nell’inverno 354-55 si reca con altri, messo del papa Liberio, dall’imperatore Costanzo per chiedergli la convocazione di un nuovo concilio per risolvere la controversia ariana. Ma chi nel sinodo tenuto nel 355 a Milano non volle sottoscrivere la condanna d’Atanasio fu esiliato.
Tra gli altri l’esilio colpì anche Lucifero il quale fu inviato a Germanicia di Commagene, poi a Eleuteropoli di Palestina e in ultimo nella Tebaide.
Di qui egli sfidava il tiranno e lo provocava con invettive come filiuspestilentiae, mendax, homicida…
Graziato da Giuliano l’Apostata si batté perché i vescovi che avevano piegato la schiena fossero sì perdonati, ma non riammessi in seno alla chiesa cattolica con la loro dignità prelatizia, sibbene come semplici gregari. Non gli fu dato ascolto. Relegatosi nella sua sede di Cagliari, e fatto da quella sua intransigenza quasi scismatico, vi morì nel 370 o 371. Durante l’esilio compose opuscoli polemici, diretti contro Costanzo, violentissimi, che ci restano insieme con un suo epistolario.
Come scrittore, è notevole per le importanti citazioni bibliche, numerosissime e di tipo italico, cioè affine al testo del codice vercellese, e per la storia del latino. Latino rozzo e volgare il suo, ma pervaso di fervore religioso quasi fanatico.
Gli si contrappone solitamente un altro celebre vescovo sardo, suo contemporaneo e amico: Eusebio da Vercelli, d’animo mite e conciliante tanto, quanto l’altro ardente e inflessibile. C’è chi ha voluto vedere in questi due contemporanei i paradigmi di due anime sarde, corrispondenti press’a poco al dualismo vigente quasi fino a ieri e già rispecchiato nello stesso codice d’Eleonora: l’antitesi tra il pastore e il contadino, tra il mangiatore di carne e il mangiatore di pane, tra un Nord e un Sud isolani che si avviano a un componimento amichevole, come nella penisola.
Stile di Lucifero, rivolto all’imperatore che lo aveva esiliato: «… tu c’impedisci ogni umano conforto, le miniere tutte e i luoghi che potevano meritare il nome di esilio riempisti delle nostre persone relegandoci innocenti e travagliandoci con la fame con la sete con la nudità.
Tu difendi i tuoi errori con la spada e noi difenderemo la religione non uccidendo ma morendo» (dal Moriendum esse pro Dei Filio).
«Rileggendo il suo latino volgare, col tono sempre acre e senza riguardi di fronte all’eretico imperatore, ho ripensato alle foreste sarde ed ai monti aspri, dai quali Lucifero respirò lo spirito robusto e combattivo» (Agostino Saba della Biblioteca Ambrosiana).
2. Strofa d’una canzone di Gavino Pes, in occasione della Guerra di Successione (per noi non c’è miglioramento / né importa chi ha vinto / sia lui Filippo quinto / o Carlo imperatore).
3. Traduzione da Livio, Historiae, XXIII, 40-41: «Col pretore Quinto Manlio si riprese la conquista della Sardegna, che era rimasta interrotta da quando il pretore Q. Mucio era caduto gravemente ammalato.
Manlio, condotte fin sotto Cagliari le sue navi, con i suoi marinai, armati in modo che potessero combattere anche per terra, e con l’esercito avuto dal pretore, riuscì a raccogliere 22 mila fanti e 1.200 cavalieri. E muovendo con queste forze di fanteria e di cavalleria verso il territorio occupato dai nemici, mise il campo non lontano dagli accampamenti di Amsicora.
Amsicora in quel momento si trovava per caso presso i Sardi Pelliti a raccogliere giovani per accrescere le sue forze.
Era comandante del campo suo figlio, Iosto: questi, pieno di giovanile baldanza, dando inizio con imprudente audacia alla battaglia, vi rimase sconfitto e poi messo in fuga.
In questa battaglia furono uccisi circa tremila Sardi e ne furono presi vivi circa ottocento. La rimanente parte dell’esercito si disperse in fuga prima per i campi e per i boschi, ma poi si ritirò nella città di Cornus, capitale di regione, dove appunto si diceva che fosse fuggito il loro capo.
Con quella battaglia si sarebbe posto fine alla guerra in Sardegna se, a dar soccorso alla ribellione dei Sardi, non fosse sopraggiunta, al comando di Asdrubale, una flotta cartaginese, la quale era stata spinta da una tempesta fin sotto le Baleari.
Manlio, quando seppe dell’arrivo della flotta cartaginese, si ritirò a Cagliari: così si lasciò ad Amsicora l’occasione di unirsi al Cartaginese. Asdrubale, dopo che ebbe sbarcato i suoi soldati e rimandata la flotta a Cartagine, mosse a devastare i campi delle popolazioni alleate dei Romani; sarebbe arrivato fino a Cagliari se Manlio, muovendogli incontro con un esercito, non gli avesse impedito la completa devastazione della campagna. Dapprima si posero gli accampamenti l’uno di fronte all’altro a breve distanza, poi si diede inizio alle incursioni e a scaramucce di poca importanza: infine si scese a battaglia, e con tutte le forze disponibili si combatté in regolare combattimento per quattro ore. L’esito del combattimento fu a lungo incerto solo per la resistenza dei Cartaginesi, perché i Sardi si lasciavano di solito vincere senza difficoltà; ma poi, quando tutto il terreno all’intorno fu pieno di Sardi uccisi o in fuga, anche i Cartaginesi furono sbaragliati: ma il duce romano, circondando quella parte del campo dove aveva ricacciato in fuga i Sardi, precluse ogni scampo ai fuggitivi. Allora il combattimento si ridusse a una feroce strage: furono uccisi 12 mila Sardi e altrettanti Cartaginesi, furono fatti prigionieri circa 37.000 uomini e conquistate 27 insegne militari.
Un bello e memorabile combattimento sostennero Asdrubale, che fu fatto prigioniero, Annone e Magone, nobili Cartaginesi: Magone era della gente dei Barca e parente prossimo di Annibale; Annone era stato il promotore della ribellione dei Sardi e senza dubbio sostenitore di quella guerra.
Anche i capi sardi resero con la loro morte memoranda quella battaglia: infatti in questa battaglia morì il figlio di Amsicora, Iosto; ed Amsicora, ormai in fuga con pochi cavalieri, quando, oltre alla sconfitta patita,seppe anche della morte del figlio, di notte, perché nessuno col suo intervento impedisse il suo proposito, si uccise».
Traduzione da Silio Italico, Punicae, XII: «Ennio disceso dall’antico re Messapo, guidava nella zuffa le prime schiere … Gli muove incontro impetuoso Iosto, sperando di farsi immortale, se gli riuscisse di ricacciare tanta rovina, e vibra con forza l’asta. Seduto su di una nuvola, Apollo rise di quel vano sforzo, e mandò l’asta a perdersi lontano, fra i venti … e la freccia mortale passò da parte a parte le tempie ad Iosto. Sgomente per la morte del giovane, si volgono in fuga per i campi le sue schiere, e tutto l’esercito in disordine si volge anch’esso alla fuga. Allora il padre, non appena udì la morte del figlio, levando barbaro e inumano grido, si trapassò il petto anelante, e dietro l’orme del figlio si affrettò ai Mani».
4. Sebastiano Satta, autore di Canti Barbaricini e di Canti del salto e della tanca; coltivò anche la poesia dialettale.
5. Launeddas. Agli albori della sua civiltà la Sardegna conosceva le launeddas, strumento simile all’aulós greco, alla dukta russa, allo scitecki cinese, al sur naj persiano, all’otou indiano e all’arghoul egiziano.
All’originale e autonoma espressione d’arte architettonica dei nuraghi preistorici e a quella della stessa epoca che riguarda la fusione dei metalli fa riscontro la sua antichissima musica: della stessa età ciclopica se non precedente la statuetta di bronzo la quale rappresenta una deità che suona le launeddas accompagnando o accennando un desiderio di danza.
Piccola statuetta, 120 millimetri, di un trenta secoli fa. Il nume impugna lo strumento formato di tre canne convergenti sulle labbra: due di queste canne sono legate e modulate dalla mano sinistra: la prima intona il canto, la seconda lo accompagna; la terza canna, libera, modulata dalla mano destra, accorda un suono grave e perenne.
Questo strumento, come rileviamo da una nota dello Zedda, dà la possibilità di produrre più di due suoni contemporaneamente, ed è la più antica testimonianza della polifonia, arte che, solo dopo il 1000, doveva essere registrata in Francia e in Inghilterra come l’inizio d’una nuova èra musicale.
Le dominazioni succedutesi nell’isola non risulta abbiano modificato questo strumento indigeno o favorito l’educazione musicale dei vinti.
Tacito (Annales, libro XIV, 3, 7, 8, 62) ricorda che Nerone esiliò in Sardegna Aniceto Alessandrino, suonatore di tibie, ma non risulta se questi abbia insegnato qualcosa ai suonatori isolani.
È certo solo che il nume dell’età nuragica modula quel canto che addormenta pecore e cani e fiumi e monti e boschi e piani ma contagia le danze ieratiche con uno strumento identico alle launeddas della grande festa di Sant’Efisio e delle sagre paesane, e che tale e quale come lui lo impugnano i viventi suonatori.
Dal VI secolo sino alle invasioni dei Musulmani, e ancora sino a quando Pisa congiunta a Genova caccerà questi dall’isola, non si trova sviluppo alcuno dell’arte musicale, se non indagando in seno alla vita ecclesiastica nelle principali sedi dell’isola. Mancano a questo riguardo specifici documenti di un’attività e d’una manifestazione propriamente musicali, sicché è possibile soltanto procedere per induzioni.
Lo stesso strumento – scrive Giulio Fara – a tre tubi di canna, con l’ancia volta verso il cono, che suonava il sacerdote nello spianato vicino al nuraghe, tuttora fa sentire la sua esile e ronzante voce nelle solennità paesane. E la stessa corona di danzatori e danzatrici, con lo stesso ieratico procedere, con gli stessi rigidi movimenti, possiamo affermare, gira lenta intorno al suonatore.
6. Paesetti tra i più miserabili del Nuorese.
7. Diana: log. yana, giana; camp. giana, azana è in Sardegna il nome delle fate che, secondo la credenza popolare, abitano le così dette domos de yanas, grotte che servirono di tombe nell’epoca nuragica (nel Nuorese si chiamano anche birghines). Queste fate vengono per lo più concepite come esseri di minuscola statura e come incantatrici dotate di bellissima voce e del dono della profezia, di modo che di una persona fortunata si dice: est affadadu beni de is gianas, e di una persona sfortunata che è isgianada; ma in alcuni paesi sono esseri malvagi e difformi, e perciò s’usa il vocabolo anche nel senso di “strega” (M. L. Wagner, La lingua sarda, pp. 124-125).
8. Fiume della Baronia (Nuoro).
Condividi su Facebook























I’m keen on your very helpful information and facts an individual offer in your content. I’ll bookmark your web site plus test all over again in this article regularly. My business is somewhat a number of My business is explained to lots of brand-new stuff appropriate below! All the best ! for an additional!
Inserisci un commento